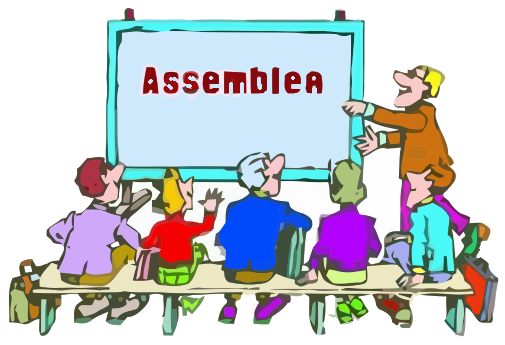Impugnazione delle delibere condominiali: il difficile rapporto tra mediazione e termini di decadenza
Mentre le delibere condominiali nulle possono essere impugnate in ogni tempo (salva la prescrizione e l’usucapione) le delibere condominiali annullabili (per la distinzione si veda Cass. SS.UU. sent. 9839 del 14.4.2021; Cass. SS.UU. sent. 4806 del 7.3.2005) possono essere impugnate (da chi non abbia votato a favore) dinanzi all’autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dalla data di adozione, per i presenti (sia di persona che per delega), o dalla data di comunicazione del relativo verbale, per gli assenti.
A seguito della introduzione anche in Italia dell’istituto della mediazione civile e commerciale (D.Lgs. n. 28 del 2010), si è stabilito che per alcune materie l’esperimento del procedimento di mediazione fosse obbligatorio, di guisa che il procedimento dinanzi al Giudice non potesse essere portato avanti se non dopo tale esperimento. Tra tali materie vi è quella del condominio, e pacificamente si ricomprendono in tale materia le controversie relative alla impugnazione delle delibere assembleari annullabili.
Conseguentemente nel suddetto termine di decadenza di 30 giorni occorre dar corso alla procedura di mediazione. Tale procedura impedisce la decadenza suddetta e ove la stessa si concluda positivamente, si sarà raggiunto lo scopo della nuova disciplina, ossia ridurre il contenzioso nelle aule di giustizia; ove si concluda negativamente, dal deposito del verbale di accertamento di tale esito negativo, decorrerà un nuovo termine di 30 giorni per introdurre la lite dinanzi al Giudice (cfr. Sentenza Tribunale Brescia, sent. 648 del 18.3.2020; Trib. Sondrio, sent. 25.1.2019; Trib. Monza, sent. 65 del 12.1.2016).
Il procedimento di mediazione deve concludersi entro 90 giorni (salvo che le parti concordemente intendano prorogare tale termine) dalla data di deposito della domanda di mediazione (art. 6).
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 succitato stabilisce che: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’Organismo” (di Mediazione).
L’art. 8 stabilisce che: “1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”.
Per il combinato disposto dei due articoli precedenti, la comunicazione che produce gli effetti di interrompere la prescrizione e di evitare la decadenza è quella con la quale l’Organismo comunica la domanda e la data del primo incontro. Tale comunicazione può avvenire anche a cura della parte istante.
Ma cosa accade se la domanda di mediazione è proposta nel termine di decadenza, ma la comunicazione della stessa e della data del primo incontro sono comunicate dopo tale termine? Ovvero come impedire la decadenza?

E’ necessaria la comunicazione della istanza e dalla fissazione della data dell’incontro nel termine di decadenza o di prescrizione
Una prima interpretazione si limita al dato temporale, e quindi ritiene che solo se la comunicazione (della domanda e della data dell’incontro) perviene entro i 30 giorni si evita la decadenza. E tale interpretazione poggia anche sul fatto che tale comunicazione potrebbe avvenire anche a cura della parte istante, come recita la norma di legge (cfr. Trib Roma, sent. 3159 del 23.2.2021, che richiama App Genova sent. 946 del 2018 e Trib. Napoli, sent. 4.12.2019, richiamando la previsione della notifica a cura della parte ex art. 6. Co 1, D.Lgs. 28 del 2010; conformi anche App. Milano, sent. 253 del 27.1.2020; Trib. Savona, sent. 111 del 8.2.2019; Cass. sent. 2273 del 28.1.2019; Trib. Genova, sent, 1665 del 11.6.2018; Trib. Ivrea, sent. 348 del 6.4.2018; App. Palermo sent. 27.6.2017; Trib. Messina, sent. 72 del 11.1.2018; Trib. Palermo, sent. 18.9.2015; in specie Trib. Roma, sent. 20267 del 22.10.2019, come i precedenti, parla proprio di comunicazione sia della domanda che della data dell’incontro). Tuttavia è evidente che se la domanda di mediazione viene presentata l’ultimo giorno utile o quelli precedenti si avrebbe una corsa contro il tempo per far nominare il mediatore, far accettare a costui la nomina e far fissare da costui la data dell’incontro, per poter poi, finalmente, procedere alla notifica. In sostanza si avrebbe una “sostanziale” riduzione del termine per evitare la decadenza, peraltro rimessa alla diligenza dell’Organismo di Mediazione scelto.
E’ sufficiente la comunicazione della sola istanza nel termine di decadenza o di prescrizione
Una seconda interpretazione, per evitare la decadenza, considera valida la comunicazione della sola domanda, ovviamente eseguita dalla parte istante, atteso che attendere la fissazione della data dell’incontro e poi la comunicazione rischia di far maturare la decadenza (cfr. Trib. Busto Arsizio, sent. 23.4.2021; App. Milano, sent. 253 del 27.1.2020: Trib. Roma, sent. 13981 del 3.7.2019; Trib. Torino, sent. 1451 del 23.3.2018; Trib Chieti – sez. Ortona, sent.3 del 15.1.2018; Trib. Napoli, sent. 10959 del 7.11.2017; Trib. Savona, sent. 2.3.2014). Ma siffatto modo di procedere non tiene conto del fatto che la norma parla di comunicazione della domanda e della data del primo incontro, e quindi la comunicazione della sola domanda appare meno di quanto la legge richiede per impedire la decadenza. Inoltre, entro quando la domanda dovrebbe essere poi depositata? Il giorno stesso o quello dopo o entro il termine di decadenza? Evidente l’arbitrio che ne nascerebbe.
E’ sufficiente il solo deposito della istanza nel termine di decadenza o di prescrizione
Una terza interpretazione ritiene che possa considerarsi idonea a evitare la decadenza il solo deposito della domanda, o meglio che il solo deposito, purché seguito dalla successiva comunicazione del ricorso e della data di incontro, sia idoneo a dare inizio al procedimento di comunicazione considerato dalla legge ai fini di evitare la decadenza.
A favore di tale interpretazione militano vari argomenti, il primo dei quali è la similitudine con il procedimento notificatorio, ove per il notificante il rispetto di eventuali termini di decadenza o di prescrizione viene valutato in relazione all’inizio del procedimento stesso o meglio a quanto costui debba fare, senza tener conto dei tempi di coloro che eseguono la notificazione e sono soggetti fuori del controllo del notificante, mentre per il notificato i termini a beneficio e a carico dello stesso sono calcolati dalla data di effettivo completamento del procedimento notificatorio (così Corte Costituzionale, sent. 26.11.2002, n. 477; Cassazione SS.UU. sent. 14.4.2011, n. 8491)). Tale componimento degli interessi contrapposti vale anche per il procedimento di mediazione, ove, specie per quello in materia di impugnazione di delibere condominiali, si adduce l’interesse del condominio alla stabilità delle delibere come motivo di interpretazione “restrittiva” del termine dei 30 giorni, ma l’imposizione di tale ulteriore onere a carico del ricorrente (ossia l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione) deve essere correttamente interpretato e giustificato (a favore di tale ragione per la scelta interpretazione qui offerta cfr. Trib. Brescia, sent. 648 del 18.3.2020; Trib. Roma, sent. 16.7.2020; Trib. Sondrio, sent. 25.1.2019; Trib. Savona, sent. 1091 del 23.10.2018; App. Brescia, sent. 133 del 30.7.2018; Trib. Palermo, sent. 4870 del 20.9.2017; Trib. Firenze, sent. 2718 del 19.7.2016; Trib. Velletri, sent. 1586 del 5.5.2015; Trib. Palermo, sent. 4951 del 2015).
In secondo luogo, la norma di legge che prevede la durata della procedura di mediazione considera come momento iniziale la data di deposito della domanda. Ma che senso avrebbe una siffatta previsione ove, ad esempio, per problemi di notifica la domanda e l’invito dovessero essere notificati dopo svariati giorni? Il senso della norma risiede nel non voler differire sine die il termine di un procedimento che è congegnato come impeditivo della trattazione delle cause da parte del Giudice. Ma allora a maggior ragione la proposizione della domanda vale a interrompere la decadenza e la prescrizione, alla quale farà seguito la effettiva comunicazione.
In terzo luogo, vi è il corretto recepimento della Direttiva 2008/52 CEE, ove all’art. 8, sotto la rubrica “effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza”, afferma che “gli Stati membri provvedono affinché alle parti, che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia, non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversi per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza”.
Ne segue che la stretta interpretazione della norma circa la comunicazione come fatto che interrompe i termini di decadenza e di prescrizione, ove sia slegato al deposito della istanza di mediazione, quale atto introduttivo del procedimento stesso, contrasta apertamente con la suddetta direttiva comunitaria, la quale nella sua essenzialità e semplicità afferma che l’intraprendere un procedimento di mediazione (ossia il presentare la relativa domanda) impedisce ogni decadenza e prescrizione durante il procedimento stesso. Con la ovvia conseguenza che la normativa nazionale – ove contrastante – debba essere disapplicata, e quindi considerata tamquam non esset.
In quarto luogo, vi è un argomento logico funzionale, relativo alla utilità della disciplina della mediazione ai fini della riduzione del contenzioso giudiziario. Nel timore che l’Organismo di Mediazione non eseguisse la comunicazione nel termine di decadenza, specialmente ove la domanda fosse presentata nella seconda quindicina del periodo, il ricorrente sarebbe indotto per cautela a proporre direttamente il giudizio, evitando ogni decadenza, e in tal sede, ove fosse sollevata la relativa eccezione o rilevata la questione d’ufficio, potrebbe poi beneficiare del termine per introdurre il procedimento (che, nota bene, si intende introdotto con il solo deposito della istanza – argumenta ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 – , e dunque rendendo ormai ancor più irrilevante data della la successiva comunicazione), ma così gravando i ruoli di procedimenti potenzialmente inutili.
In conclusione, l’unica interpretazione della disciplina giuridica del rapporto tra mediazione e decadenza in materia di impugnazione delle delibere condominiali annullabili ragionevole, compatibile con lo spirito della nostra Costituzione e conforme alle direttive comunitarie, risulta quella secondo la quale la decadenza è evitata ove la domanda sia presentata ad un Organismo di Mediazione entro il termine di 30 giorni.
Avv. Giorgio Falini